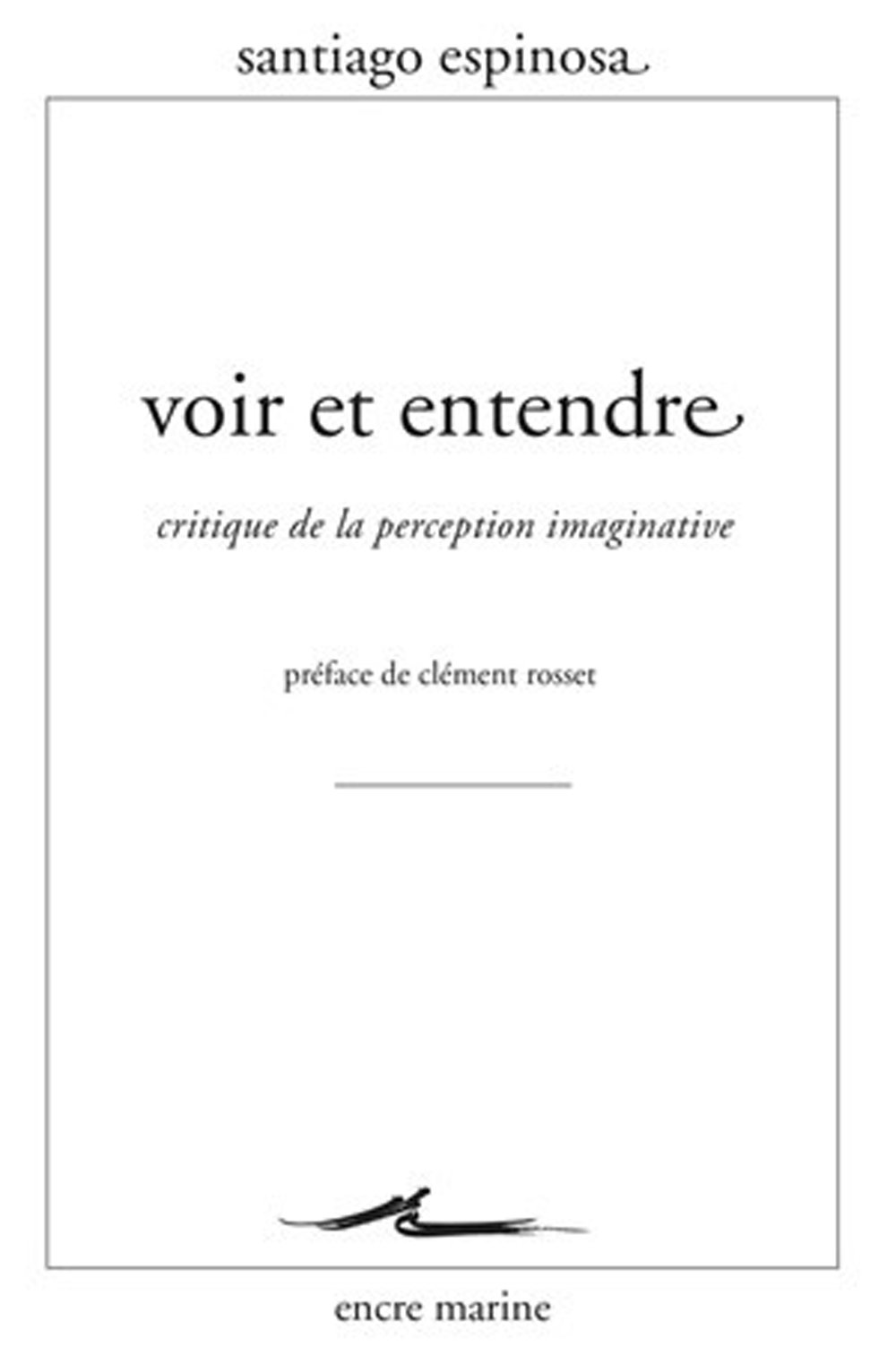Non sapendo ascoltare,
non sanno neanche parlare.
Eraclito
L’occhio ascolta è, come è noto, il titolo di un lavoro dello scrittore Paul Claudel che raccoglie alcuni articoli sull’opera d’arte e, in particolare, sulla pittura. Il titolo è sorprendente da molti punti di vista. A rigor di termini, non vuol dire niente: l’occhio vede, guarda, riceve delle impressioni luminose, percepisce delle nuances di colore — al limite, si può dire che rende possibile l’immagine (ma questo è un problema sul quale ritorneremo più avanti). L’ascolto non ha niente a che vedere con tutto questo: nessuna luce o colore in senso letterale; esso è prodotto attraverso delle vibrazioni nell’aria, che non sono all’origine di alcun tipo di immagine. Naturalmente, Claudel non parla in senso stretto, organico e materiale del termine. Vuole dire che l’opera d’arte deve essere presa, per essere «compresa», mediante un doppio richiamo allo spettatore: da un lato attraverso un assemblaggio di forme materiali (linee, colori, spazi), dall’altro per il tramite di un significato, di un’idea che solo lo spirito è in grado di afferrare. In altre parole, non dovremmo accontentarci di guardare un dipinto se vogliamo coglierne la bellezza, ma dovremmo leggerlo e quindi interpretarlo.
È proprio per questo che Claudel sente di dover usare la facoltà uditiva. In effetti, per lui tutto sembra a prima vista doppio. Da un lato, ci sono ancora i suoni, il materiale sonoro puro, l’aria che vibra e colpisce il nostro timpano; dall’altro, c’è il senso, le idee tutte spirituali che lo spirito — o, diciamolo francamente, poiché Claudel non nasconde il suo gioco: l’anima — è capace di sentire, intendere (nel doppio significato del termine francese “entendre”: sentire i suoni e comprenderne il senso) attraverso, per mezzo dei suoni. Doppia sensibilità quindi, se non tripla: sensibilità ai suoni, sensibilità al significato trasmesso da questi suoni, spiritualità aggiunta, poiché l’udito «traduce» il significato percepito — il significato letterale di un testo per esempio — nel senso spirituale, non percepito: nascosto, criptato — la verità che comprendiamo attraverso il testo. «Sta a noi ascoltarlo – scrive Claudel – prestare l’orecchio ai sotto-intesi». Il sotto-inteso, ecco l’affare dell’artista tanto quanto quello dello spettatore: tutto ciò che è «detto ad alta voce» nell’opera — dipinta, scritta, mostrata — vuol dire un’altra cosa «a bassa voce» — un messaggio non sensibile. Un contenuto che non è da ascoltare, ma da intendere [entendre]; non da udire ma da pensare.
Questo modo di considerare l’ascolto, che mi sembra tutt’altro che soddisfacente, almeno nel campo dell’arte (si capisce che sia quindi considerato in termini di significato linguistico), ha tuttavia una lunga storia in filosofia ed è ampiamente diffusa al giorno d’oggi. Hegel scriveva nella sua Estetica che l’udito è il senso più «intellettuale» di tutti nella misura in cui cattura, attraverso i suoni, gli «echi dell’anima». Più vicino a noi, Heidegger, ci dice che ascoltare significa «raccogliersi in sé stessi» per comprendere un significato, il logos (si veda la sua lezione con questo titolo) che significa alla fine, interpretare. Egli scrive: «Siamo tutto orecchie quando il nostro raccoglimento è trasportato, puro, nel nostro potere di ascoltare, quando ha completamente dimenticato le orecchie e la semplice impressione dei suoni».
Ascoltare, come di seguito lo ripetono a piacere i fenomenologhi — auscultare — significa allora «prestare l’orecchio» non a ciò che è percettibile, i suoni, ma proprio a ciò che non lo è, a ciò che non si ascolta, all’impercettibile, al sottinteso (quindi al non sentito). Ascoltare, è tendere verso un senso, e senso qui vuol dire «rinvio», ciò significa non fare attenzione e non prendere in considerazione ciò che è presente, qui, ora (i suoni), ma «essere tesi verso» qualcos’altro. Rimane solo da decifrare, da estrarre dalla sua cripta questo «qualcos’altro».

Comprendiamo quindi le bizzarre analisi che i filosofi generalmente fanno sulla musica: se i suoni che si ascoltano sono il veicolo di un messaggio che non si ascolta, allora l’atteggiamento dell’ascoltatore non può essere una attenzione passiva, l’ascolto non può essere ricezione di un senso già dato, pretendendo di essere preso in considerazione come tale, ma dovrebbe essere, al contrario, attivo, indirizzando la sua attenzione sull’oggetto che questi suoni cercano invano di designare, cercando di tradurre cosa significhi dire senza mai paradossalmente riuscire a dirlo. Il senso della musica non può essere trovato nella musica stessa — nei suoni, nelle note organizzate nel tempo, nei giochi e nelle variazioni con i temi che si possono ascoltare — ma si troverebbe perennemente altrove, «Tra le righe, tra le note». Pertanto, parlare di musica significa parlare di tutto, con l’esplicita eccezione dell’oggetto strettamente musicale. L’ascoltatore che sembra aver «capito» il Bolero di Ravel e che, interrogato su questo argomento, si accontenterebbe di canticchiarlo correttamente a tempo, sarebbe scambiato per l’ultimo degli ingenui, per un uomo simpatico, ma tutto sommato un po’ sempliciotto.
Amando la musica sopra tutte le arti (che adoro), mi rifiuto di prenderla per qualcosa di diverso da se stessa, e dirò più avanti perché il punto di vista che ho appena accennato brevemente mi sembra, anche se ampiamente diffuso, indifendibile. La musica è musica, è fatta di suoni, e questi suoni non sono il veicolo di nient’altro che loro stessi. I suoni sono tutto quello che c’è da capire nella musica; essi sono il senso, e comprendere il senso musicale equivale ad ascoltarli e, come scrive splendidamente Charles Rosen, a «sentirsi bene» con loro. Ma prima di arrivare ad una breve elaborazione di questo argomento, è importante per me cercare di capire da dove viene questo particolare modo di considerare l’ascolto che serve la musica (e in un certo senso la filosofia), che è, lo ripeto, molto comune – il che spiega perché la maggior parte delle persone che si avventurano a parlare di musica sono, come si dice di alcuni compiti degli studenti in Francia, fuori tema.
A dire il vero, tutto ciò che è stato detto finora sull’ascolto, si può anche dire della vista, ciò che giustifica il titolo del libro di Claudel. Heidegger lo scrive senza mezzi termini nella conferenza prima citata: «Se rimane un “aver-visto “, il cui ” vedere ” non è quello degli occhi del corpo, tanto quanto “l’aver-sentito” è un sentire degli organi dell’udito, allora verosimilmente aver-sentito e aver-visto sono identici». In altre parole, se vedere e sentire sono due attività che implicano l’interpretazione di impressioni sensibili al fine di cogliere un significato dal quale differiscono, è ovvio che non importa quale organo sia all’origine dell’impressione che si presta all’interpretazione, che fa la coscienza da parte sua, poiché il senso colto dall’uno o dall’altro è precisamente uno e lo stesso. Si dirà allora che l’occhio ascolta nella stessa misura in cui si può dire che l’udito vede. Ascoltare e vedere sono gli intermediari dell’attività della coscienza (intesa in senso trascendente, cioè metafisico: è ciò che, presumibilmente, rende l’esperienza possibile). Non è necessario, del resto, accontentarsi di identificare queste due sensazioni: ogni sensazione fa, da questo punto di vista, la stessa cosa. Levinas, ad esempio, scrive: «Vediamo la durezza di un oggetto, il sapore di un piatto, l’odore di un profumo, il suono di uno strumento, la verità di un teorema». Strano proposito, a prima vista aberrante, che tuttavia diventa comprensibile dal momento in cui lo si accetta – ed è l’essenza della questione – che, secondo una tradizione ancestrale, millenaria, vedere è sapere.
In passato mi sono soffermato sull’evoluzione dell’etimologia comune di queste due nozioni [voir e sa-voir in francese (-weid)], simili, ma tuttavia, abbastanza diverse. Vedere è, come ho detto, ricevere un’impressione retinica della luce — onda o corpuscolo — ; sapere è conoscere la verità di un oggetto che pensiamo. Si sa che in Descartes l’intero metodo si basa sull’evidenza, sull’intuizione chiara e distinta dello spirito; Qualunque cosa stia dicendo è, almeno qui, molto vicino ad Aristotele che scrive fin dalle prime righe della Metafisica che il piacere di vedere che si ritrova nel bambino dimostra fin d’ora che l’uomo è portato naturalmente a fare della scienza. E la scienza vera è quella che è evidente, quella che si vede. Ogni filosofia di tipo platonico si basa in ultima analisi sul modello della visione: le idee immutabili non sono nient’altro che le immagini delle cose che cambiano. Poiché l’immagine ha questa virtù (o questo vizio?) che consiste nell’immobilizzare la durata, nel togliere ogni riferimento temporale alle cose che si percepiscono. Donate a queste immagini un nome e avete l’eidos. Si capisce quindi il legame che collega il vedere e il sapere: sapere è afferrare, dietro la cosa sensibile, passeggera e cangiante, ciò che essa si suppone non cambi, e che, di conseguenza, fa che sia quello che è. La nozione di essenza è il risultato di una tale visione: è l’immagine — il «ritratto» della cosa, come dice Descartes — che è vera, non la cosa vista. Senza dubbio la nozione stessa di Essere è il prodotto più sorprendente di questa identificazione delle cose e delle immagini.
Non si tratta qui di citare tutte le occorrenze o tutti gli effetti di questa associazione tra la vista e la conoscenza. É sufficiente dire che essa è all’origine del privilegio di cui beneficia la vista in campo filosofico, che ha sempre ritenuto che essa fosse il senso più nobile, e che talvolta si è presa essa stessa come una teoria della conoscenza. Sarebbe altrettanto inutile cercare di togliergli un tale primato o prestigio. Tuttavia, va osservato che, quando parliamo della vista come mezzo di conoscenza, non parliamo, come abbiamo appena detto, dell’atto di vedere in senso stretto. Non stiamo parlando dell’impressione retinica, ma di un atto dello spirito, di una «visione dell’anima», come suggerisce, per esempio, Platone nel Fedone temendo di rendere cieco quest’ultimo prestando troppa attenzione alla visione degli occhi. Parliamo in una parola di immagini.
Ed è qui che sorge il problema: non c’è immagine del reale — è per questo che ogni teoria (theôria = visione) della realtà è essenzialmente destinata al fallimento, come mostra a prima vista la storia delle scienze, e questo fino ad oggi (si cerca ancora, nel campo della fisica, la «buona immagine», ed è forse la ragione per cui ancora non si riesce a ottenerla — anche se la meccanica quantistica ha già iniziato a disinnescare questo desiderio di rendere un’immagine dell’universo). Il reale — ciò che esiste —, come diceva il mio maestro e amico Clément Rosset, è senza un’immagine alla sua altezza. Ecco cosa scrive nel suo Traité de l’idiotie (Trattato dell’idiozia):
Tutte le cose, tutte le persone sono così idiote — da idiôtès [in greco] unico, singolare —poiché esistono solo in se stesse, cioè non sono in grado che di apparire là, dove esse sono e quali sono: incapaci dunque, e in primo luogo, di riflettersi, di apparire nel doppio dello specchio. Ora, è il destino finale di ogni realtà quello di non potersi duplicare senza diventare subito altro: l’immagine offerta dallo specchio non è sovrapponibile alla realtà che suggerisce. È il caso, in particolare, dell’universo, che Ernst Mach ha descritto in una formula molto strana e molto profonda, come «un essere unilaterale il cui complemento a specchio non esiste o, almeno, non ci è noto».
Se la vista è stata considerata il «senso per eccellenza» è perché si è fatto presto ad associare la realtà a ciò che si vede, e con ciò ad un’immagine. Immagine dai contorni ben definiti, quali le «forme» o le «idee» — «ecco un albero, un cane, un uomo» — di cui il linguaggio può poi rendere conto. È così che appare l’idea secondo cui l’anima fornisce un’immagine vero-simile delle cose, o ancora che essa stessa è «l’insieme delle realtà», come si può leggere nel De anima di Aristotele. Non si può pensare senza immagini, scrive, e le immagini sono le cose stesse. Il legame con la grammatica, o piuttosto la «logica» è d’ora in avanti tracciato: una parola rimanda ad un’immagine, da cui ne consegue che il pensiero è in grado di conoscere il reale. Ma appunto: nessuna cosa ha un’immagine alla sua altezza. Tutto si trova nel flusso continuo, il panta rhei eracliteo dove una cosa è, e allo stesso tempo, non è la stessa, dove un fiume è, e non è lui, proprio come uno che pretende di bagnarsi. Che cosa è, vi chiedo, una «cosa»? E voi stessi chi siete? Né l’immagine né il nome possono renderne ragione. What’s in a name? — Ecco la grande domanda di Giulietta, che cerca di sapere, non chi è Romeo, cosa che lei sa fin troppo bene, ma che cosa sia un nome: non è né una mano, né un piede, né un braccio, né un volto. Un nome non è niente — eppure si presenta come il nemico. — Deny thy father and refuse thy name... — Ecco perché Giulietta si rifiuta, poco dopo, che Romeo giuri su qualsiasi cosa, se non su se stesso (thy gracious self), se vuole essere preso sul serio nei suoi giuramenti d’amore. L’immagine, fissa, irrigidisce la realtà; volendogli attribuire una forma — firmus (fermo), frenus (freno), fretus (sostegno, supporto) —, la deforma, la altera (la rende altro da sé). Il reale sfugge all’immagine perché tutto ciò che esiste nell’universo è uno, unico, irripetibile, passeggero, cangiante. Diciamolo chiaramente: l’immagine è incapace di cogliere la realtà perché deve necessariamente privarla dell’essenza (se ci si può ancora servire di un simile concetto), cioè la durata. Per l’immagine tutto è eterno, compresa la sua antitesi esatta, il tempo, che secondo Platone è un «immagine mobile», quindi difettosa, «dell’eternità». Divertente definizione, poiché è proprio dell’immagine di mancare non solo di cambiamento, ma soprattutto di mobilità. È piuttosto l’eternità che si presenta come immagine deformante della realtà mutevole.
Ed eccoci immersi nel vero problema: la durata non può essere percepita in quanto tale? La percezione umana, presumibilmente soggetta, come abbiamo visto, alle prerogative della coscienza, è essenzialmente interpretativa — rendendo sempre una cosa in un’altra, A rinvia a B, non potendo dunque mai cogliere A in quanto A? Pensare il reale significa per forza farne un’immagine?
Prima parte della conferenza tenuta da Santiago Espinosa al Festival A due voci 2018